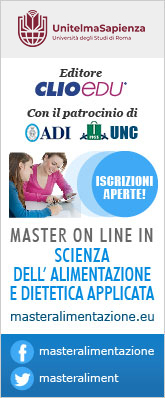Modalità di navigazione
Accesso rapido
Sezioni presenti sul sito
Eventi e speciali
Memorie della terra. Racconti e canti di lavoro e di lotta del Salento
Le storie del tabacco e la rivolta di Tricase del 1935
Informazioni utili
- Categoria: Teatro / Spettacoli
- Data: 26/07/2009
- Dove: Tricase
- Indirizzo: Palazzo Gallone
- Orario: 21:00
- Organizzatori: Pro Loco
Testi di Vincenzo Santoro
voci narranti: Vincenzo Santoro e Anna Cinzia Villani
canti eseguiti da: Daniele Girasoli (voce, tamburello, cucchiai, armonica a bocca) Maria Mazzotta (voce, tamburello, cupa cupa) Enrico Noviello (voce, tamburello, chitarra battente) Anna Cinzia Villani (voce, organetto diatonico, armonica a bocca, tamburello)
Lo spettacolo sarà preceduto dalla presentazione del libro "I leccesi a Civita Castellana. Storia di emigrazione e di tabacco" di Irene Mancini, Edizioni della Biblioteca Comunale "E. Minio" di Civita Castellana. Partecipano l'autrice e Alfredo Romano, direttore della Biblioteca comunale di Civita Castellana (Viterbo)
15 maggio 1935. A Tricase, cittadina dell'estremo lembo meridionale del Salento, le operaie tabacchine scendono in piazza per protestare contro la volontà degli esponenti locali del Regime fascista di trasferire in un altro luogo il "Consorzio", lo stabilimento dove si lavorava il tabacco, eliminando così di colpo centinaia di posti di lavoro. La manifestazione presto degenera in un vero e proprio assalto al Municipio, che la forza pubblica respinge sparando sulla folla. Alla fine degli scontri, il bilancio di questa tragica vicenda sarà di cinque morti e diverse decine di feriti, e in seguito - anche per la dura repressione condotta dal Regime - una cappa di silenzio calerà su quella che Giuseppe Di Vittorio definirà "la rivolta di Tricase".
Di questa e di altre storie tratta lo spettacolo Memorie della terra, in cui musica e racconto orale si intrecciano in un viaggio nella memoria del lavoro agricolo nel Salento della prima metà del novecento, il periodo storico che vide i lavoratori della terra reagire alle condizioni di odioso sfruttamento con una grande stagione di lotte politiche e sociali, culminate negli scioperi delle operaie tabacchine e nell’occupazione delle terre del feudo d’Arneo. Nel corso dello spettacolo, la lettura di alcuni racconti - tratti da una ricerca condotta a partire dalle testimonianze orali dei protagonisti - viene affiancata dall’esecuzione di canti tradizionali di argomento “politico e sociale”, che in molti casi contengono espliciti riferimenti alle vicende narrate (tra gi altri: Lu sule calau calau, Fimmene fimmene, La tabbaccara, Madonna mia ce sta succede, Le tabbacchine di Aradeo, Maledettu lu Cinquanta, Scusati amici cari, Il canto dell'Arneo). Altri canti accompagnano lo svolgimento dello spettacolo: La cupa cupa vene de Pasticcia e La masseria Stranese sono la "colonna sonora" dei lavori stagionali in Lucania, il lamento funebre ricorda i morti di Tricase, Canaja canaja e La Ceserina sono canti del carcere. Ne emerge un racconto avvincente di una stagione fondamentale per l’emancipazione delle plebi meridionali e per l’affermazione dei diritti civili e sociali nel nostro paese, vista “dal basso”, dalla narrazione viva dei protagonisti.
I leccesi a Civita Castellana. Storia di emigrazione e di tabacco Civita Castellana è una popolosa cittadina della provincia di Viterbo, famosa per la produzione di ceramiche su scala industriale. Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, alcuni proprietari terrieri locali, sfruttando gli incentivi statali, decisero di introdurre nel territorio circostante la coltivazione del tabacco, attirati dal miraggio dei lauti guadagni che il sistema dei monopoli poteva garantire loro. Il tabacco però era una coltura difficile, che richiedeva manodopera specializzata, di cui Civita era sprovvista. Questi proprietari decisero così di rivolgere la loro attenzione al Salento, dove gente capace di coltivare il tabacco ce n’era tanta, e dove i lavoratori della terra vivevano per la maggior parte in condizioni di povertà e sfruttamento, e quindi potevano essere disposti a spostarsi a Civita in cambio di una prospettiva migliore (anche se non di molto). Cominciò così l’esodo di alcune centinaia di tabacchicultori salentini, che lasciarono i loro paesi d’origine per raggiungere il viterbese, in molti casi portandosi dietro anche le famiglie e formando una piccola comunità di emigranti. Dai civitonici venivano chiamati, un po’ dispregiativamente, “i leccesi”.
voci narranti: Vincenzo Santoro e Anna Cinzia Villani
canti eseguiti da: Daniele Girasoli (voce, tamburello, cucchiai, armonica a bocca) Maria Mazzotta (voce, tamburello, cupa cupa) Enrico Noviello (voce, tamburello, chitarra battente) Anna Cinzia Villani (voce, organetto diatonico, armonica a bocca, tamburello)
Lo spettacolo sarà preceduto dalla presentazione del libro "I leccesi a Civita Castellana. Storia di emigrazione e di tabacco" di Irene Mancini, Edizioni della Biblioteca Comunale "E. Minio" di Civita Castellana. Partecipano l'autrice e Alfredo Romano, direttore della Biblioteca comunale di Civita Castellana (Viterbo)
15 maggio 1935. A Tricase, cittadina dell'estremo lembo meridionale del Salento, le operaie tabacchine scendono in piazza per protestare contro la volontà degli esponenti locali del Regime fascista di trasferire in un altro luogo il "Consorzio", lo stabilimento dove si lavorava il tabacco, eliminando così di colpo centinaia di posti di lavoro. La manifestazione presto degenera in un vero e proprio assalto al Municipio, che la forza pubblica respinge sparando sulla folla. Alla fine degli scontri, il bilancio di questa tragica vicenda sarà di cinque morti e diverse decine di feriti, e in seguito - anche per la dura repressione condotta dal Regime - una cappa di silenzio calerà su quella che Giuseppe Di Vittorio definirà "la rivolta di Tricase".
Di questa e di altre storie tratta lo spettacolo Memorie della terra, in cui musica e racconto orale si intrecciano in un viaggio nella memoria del lavoro agricolo nel Salento della prima metà del novecento, il periodo storico che vide i lavoratori della terra reagire alle condizioni di odioso sfruttamento con una grande stagione di lotte politiche e sociali, culminate negli scioperi delle operaie tabacchine e nell’occupazione delle terre del feudo d’Arneo. Nel corso dello spettacolo, la lettura di alcuni racconti - tratti da una ricerca condotta a partire dalle testimonianze orali dei protagonisti - viene affiancata dall’esecuzione di canti tradizionali di argomento “politico e sociale”, che in molti casi contengono espliciti riferimenti alle vicende narrate (tra gi altri: Lu sule calau calau, Fimmene fimmene, La tabbaccara, Madonna mia ce sta succede, Le tabbacchine di Aradeo, Maledettu lu Cinquanta, Scusati amici cari, Il canto dell'Arneo). Altri canti accompagnano lo svolgimento dello spettacolo: La cupa cupa vene de Pasticcia e La masseria Stranese sono la "colonna sonora" dei lavori stagionali in Lucania, il lamento funebre ricorda i morti di Tricase, Canaja canaja e La Ceserina sono canti del carcere. Ne emerge un racconto avvincente di una stagione fondamentale per l’emancipazione delle plebi meridionali e per l’affermazione dei diritti civili e sociali nel nostro paese, vista “dal basso”, dalla narrazione viva dei protagonisti.
I leccesi a Civita Castellana. Storia di emigrazione e di tabacco Civita Castellana è una popolosa cittadina della provincia di Viterbo, famosa per la produzione di ceramiche su scala industriale. Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, alcuni proprietari terrieri locali, sfruttando gli incentivi statali, decisero di introdurre nel territorio circostante la coltivazione del tabacco, attirati dal miraggio dei lauti guadagni che il sistema dei monopoli poteva garantire loro. Il tabacco però era una coltura difficile, che richiedeva manodopera specializzata, di cui Civita era sprovvista. Questi proprietari decisero così di rivolgere la loro attenzione al Salento, dove gente capace di coltivare il tabacco ce n’era tanta, e dove i lavoratori della terra vivevano per la maggior parte in condizioni di povertà e sfruttamento, e quindi potevano essere disposti a spostarsi a Civita in cambio di una prospettiva migliore (anche se non di molto). Cominciò così l’esodo di alcune centinaia di tabacchicultori salentini, che lasciarono i loro paesi d’origine per raggiungere il viterbese, in molti casi portandosi dietro anche le famiglie e formando una piccola comunità di emigranti. Dai civitonici venivano chiamati, un po’ dispregiativamente, “i leccesi”.
Link utili
ClioCom © copyright 2026 - Clio S.r.l. Lecce - Tutti i diritti riservati